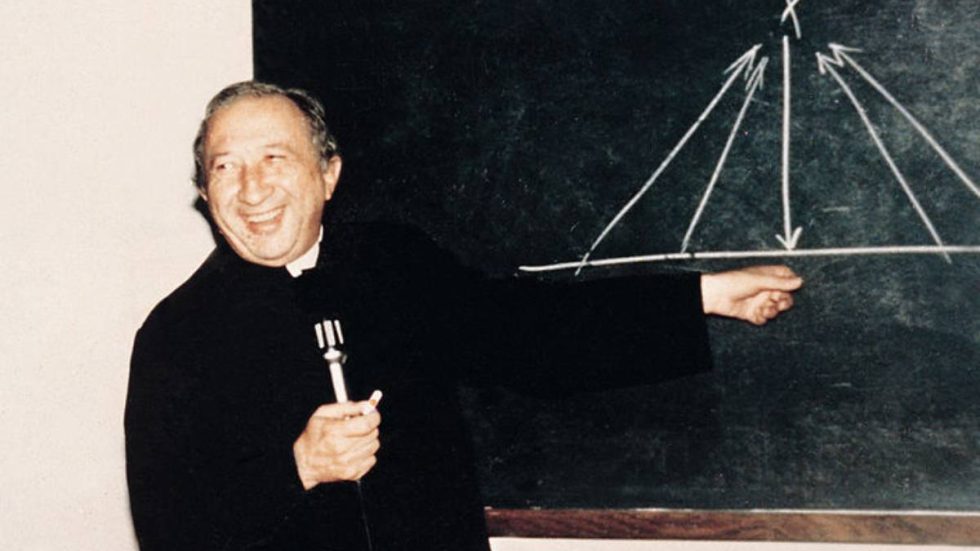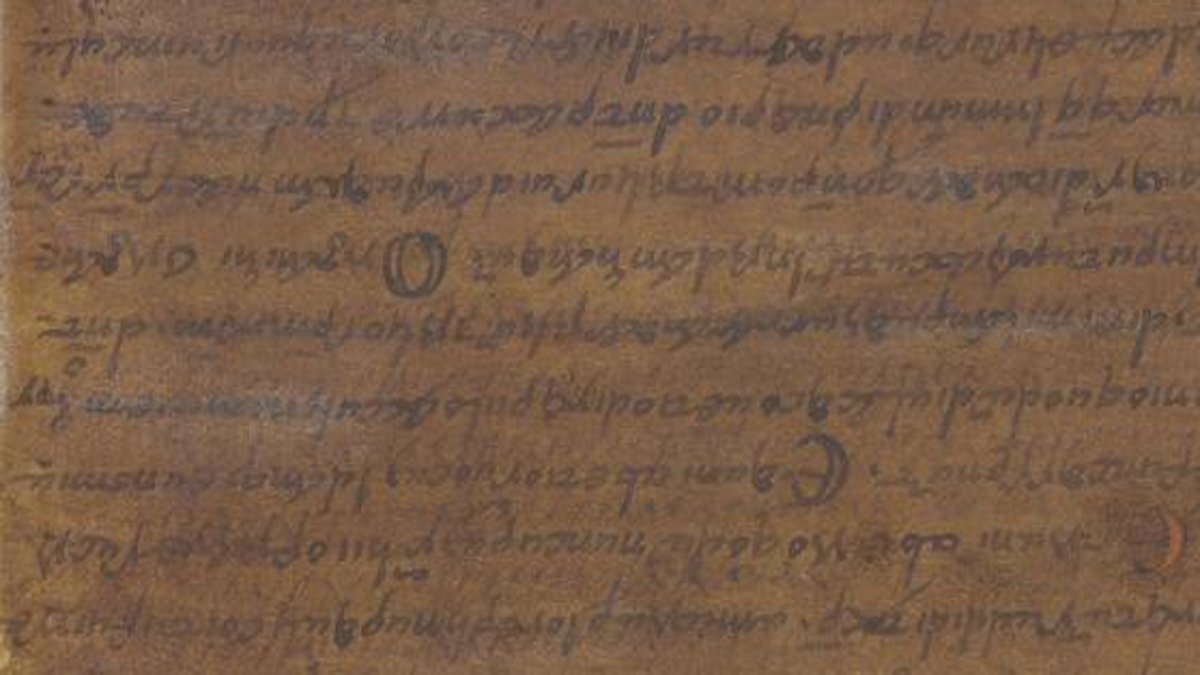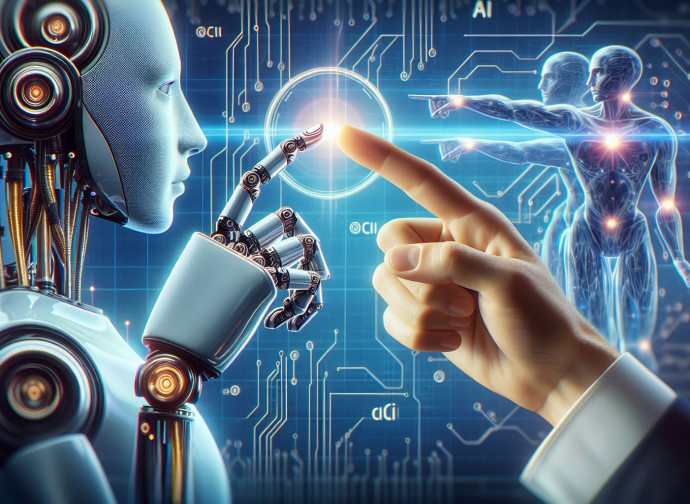Attualità
Nell’ospedale psichiatrico di Betlemme tuffo nel dolore
L’Autorità palestinese non ha i soldi per pagare gli stipendi e riesce a fornire solo l’essenziale per la sopravvivenza. Qui si trovano non solo i malati mentali, ma anche disabili, anziani, persone depresse segnate dal conflitto. E poi vittime della solitudine, della mancanza di lavoro, di sicurezza, oppresse dal muro israeliano. Tanti non dovrebbero essere neppure qui. Basterebbero cure molto semplici, ma...

“Vivo in una piccola prigione posta dentro una grande galera, circondata da un muro alto di cemento che non mi fa vedere nulla. Mi piacerebbe tornare ad abitare nella mia casa. Qui nessuno viene mai a trovarmi, ma la vita è un gioco, chi vince ride e chi perde piange”. Lo sguardo di Ibrahim, 67 anni, sembra perso nel vuoto mentre racconta – in un discreto italiano, lui che per anni ha lavorato a Gerusalemme come stampatore presso la Custodia francescana – la sua vita di ospite nel manicomio nazionale di Betlemme. Vicino a lui Rita, sua sorella, anche lei degente dell’ospedale. Sessantuno anni, un passato da insegnante di inglese e poi i primi sintomi di disagio mentale, schizofrenia. Intorno a loro i resti di un giardino lasciato nell’incuria più totale, erbacce alte coprono il muretto di cinta aggredendo la rete metallica arrugginita posta a protezione, calcinacci e rifiuti sparsi lungo il viale di quel che resta di un ambizioso edificio di epoca ottomana (1880) che ancora mostra i resti fatiscenti di due eleganti scalinate di ingresso. In quel tempo vi trovavano rifugio i poveri e gli affamati della città perché chi poteva emigrava, soprattutto in Sud America. Oggi, a fianco del corpo originale dell’ospedale si trovano alcuni padiglioni più recenti per circa 300 posti letto totali. A riempirli i poveri dei nostri giorni, quelli che a Betlemme rispondono al nome non solo di malati mentali, ma di disabili, anziani, persone depresse segnate dal conflitto, dalla solitudine, dalla mancanza di stabilità, di lavoro, di sicurezza, oppresse dal muro israeliano che impedisce loro ogni movimento, stimolando allo stesso tempo rabbia e rassegnazione, quella che ti fa vivere a Betlemme, “grande galera” a cielo aperto. Il degrado dell’ospedale è lo specchio delle difficoltà dello Stato palestinese che non riesce a garantire investimenti sanitari e cure dignitose a queste persone, almeno 2000 quelle che quotidianamente vengono qui per essere visitate. Gli unici interventi sono garantiti da donatori stranieri quali l’Unione europea e Usaid, come testimoniano alcuni sbiaditi cartelli di esecuzione lavori affissi sulle zone più nuove dell’ospedale ma che non datano oltre il 2010. “L’Autorità palestinese non ha soldi nemmeno per pagare gli stipendi e riesce a fornire solo l’essenziale per la loro sopravvivenza” spiega Vincenzo Bellomo, direttore della Caritas Betlemme e responsabile dei progetti di Ats Pro Terra Sancta, la ong della Custodia di Terra Santa. “Mancano progetti di riabilitazione, programmi specifici per i malati, che negli ambienti comuni vivono tutti insieme, senza distinzione di età e senza tenere conto delle diverse patologie mentali” aggiunge Angie Zoughbe, infermiera di Betlemme che, quando gli studi lo permettono, presta la sua opera come volontaria per Ats. Nell’ospedale ormai la conoscono tutti. Soprattutto Ibrahim e Rita, gli unici due degenti di fede cristiana, ma anche gli altri ricoverati nei reparti “cronici” e “acuti”. Le loro mani escono dalle grate, cercando di avvicinarla, la chiamano, urlano. Tra loro anche giovani donne. Riescono a farsi capire con i gesti, dicono che soffocano, vogliono soldi e sigarette, mostrano le loro mani fuori dalle grate, con anellini e braccialetti, forse l’unico vezzo di una vita buia. “Nessuno viene mai a trovarli – racconta l’infermiera – la salute mentale qui a Betlemme, e in tutta la Cisgiordania non dipende solo dalla medicina ma anche dalla situazione socio-politica. Forse è anche per questo che non ci sono giovani che affrontano gli studi di psichiatria. Chi lo fa si reca all’estero. Non abbiamo una vera unità di salute mentale”. Ma c’è anche un problema culturale: “La disabilità è percepita come uno stigma, una vergogna sociale da nascondere. I familiari con disabilità sono tenuti nascosti in casa o portati in strutture come questa di Betlemme e lasciati al loro destino”. Avrebbero bisogno di cure e di quiete, di ambienti sani, di vestiti puliti, di cibo decente, di attività da svolgere ma la loro vita si accartoccia intorno ad una televisione sempre accesa, tra le mura di saloni vuoti, accovacciati in qualche angolo. Non si vedono medici in giro per i padiglioni, qualche infermiere, tutti con poca voglia di parlare. Anche il parcheggio è vuoto, ma forse solo perché è pomeriggio e il turno lavorativo è finito. Di parenti in visita nemmeno l’ombra. “Facciamo quel che possiamo per alleviare le condizioni di vita di queste persone – dice Bellomo -, con Ats negli ultimi 5 anni siamo riusciti a recuperare 20 persone. Non erano malati mentali ma lo stavano diventando a forza di restare qui. Spesso vengono ricoverati perché anziani o soli, incapaci di provvedere a se stessi, ma una volta accolti in case famiglia riprendono forze e stimoli. Alcuni hanno piccole disabilità o lievi ritardi che possono essere trattati con adeguate cure e terapie che spesso il manicomio non offre”. Ma qualcosa sta cambiando. Il ministero della Salute palestinese lavora per incrementare progetti di cura individuali e programmi di prevenzione. Ma forse per Ibrahim, sua sorella Rita e gli altri malati sarà troppo tardi. Ibrahim lo sa bene, per questo ripete sempre: “La vita è un gioco, chi vince ride e chi perde piange”.