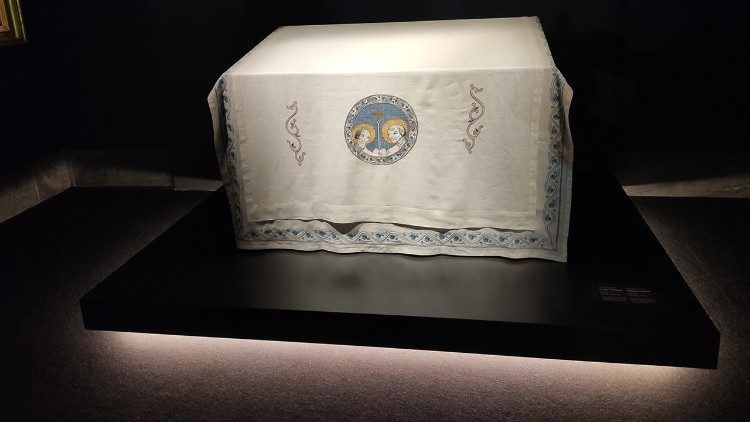Cultura
Artisti, letterati e religiosi tra i pellegrini del Giubileo del 1600

La luce simboleggia la grazia di Dio che vince sulle tenebre e attende di essere accolto dall’uomo
Caravaggio, a cui è dedicata la mostra a Palazzo Barberini per il Giubileo 2025, prese parte all’Anno di Grazia inaugurato da Papa Clemente VIII con l’apertura della Porta Santa il 31 dicembre 1599. Il 12° Giubileo della storia della Chiesa cattolica fu indetto con la bolla Annus Domini placabilis del 19 maggio 1599, seguita dalla sospensione delle altre indulgenze con la bolla “Cum sancti jubilaei” e con il breve apostolico “Tempus acceptabile”, con cui il santo padre esortò tutti i vescovi a prepararsi al Giubileo organizzando pellegrinaggi a Roma. Questo meraviglioso evento si aprì in un periodo di profonda trasformazione culturale con la nascita del Barocco, lo stile tipico della Controriforma in grado di esprimere, in forme grandiose e iperboliche, i valori e i poteri delle grandi famiglie principesche e della stessa Chiesa, con la tendenza alla spettacolarizzazione e al superamento della severità e del tetro rigore tridentino. Clemente VIII, tuttavia, seguì pedissequamente le indicazioni date dal Concilio di Trento per la riforma della Chiesa, assumendo una condotta sobria e dedita alla penitenza e al digiuno. Cercò di favorire un Giubileo che permettesse veramente ai pellegrini di convertirsi, calmierando i prezzi degli affitti, migliorando le condizioni igieniche dell’Urbe, facendo ripulire le strade, vietando la circolazione di animali e le feste. Caravaggio era a Roma durante quell’anno santo e terminò in tempo due tele: la Vocazione di San Matteo e il Martirio di San Matteo. Gli furono commissionate dal cardinale Francesco Maria Del Monte per la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, nei pressi di Palazzo Madama, allora abitazione dello stesso prelato. Questa cappella, dedicata a San Matteo e affrescata nella volta, qualche anno prima, dal Cavalier d’Arpino con un linguaggio ancora tardomanierista, accoglie, oltre a questi due capolavori, anche la pala d’altare con San Matteo e l’Angelo (1602). Caravaggio affrontò quest’impegnativa prova su temi di storia sacra, con soluzioni di assoluta novità: le vicende del santo non sono idealizzate ma, al contrario, si svolgono in ambienti reali, animati da uomini comuni. La Vocazione coglie il preciso momento in cui Matteo, l’esattore delle tasse, viene chiamato all’apostolato da Cristo. La rivoluzione pittorica di Caravaggio consiste nel fatto che una scena profana assume una valenza sacra, in rapporto alla chiamata del Signore. Un’altra novità è che il pittore lavora sulla tela e non su disegni preparatori, usando poche tinte per lo più brune, con gradazioni smorzate e facendo emergere le figure dai fondi scuri con progressivi schiarimenti di toni. La luce è protagonista della scena, simboleggia la volontà di Dio ed è resa in modo realistico. Nel Martirio viene raffigurata l’azione di condanna di Matteo, che viene colpito mentre si trova sdraiato a terra con la mano in direzione dell’angelo che gli offre la palma. La scena drammatica si verifica in uno spazio simile ad una Chiesa e sta avvenendo a messa conclusa. La rappresentazione del reale nella sua forma più cruda rientra nell’intento del Merisi, che sceglie di dare più risalto al sicario posto in primo piano, con un corpo monumentale, in atteggiamento aggressivo e con una spada nella mano destra, pronto a fendere il colpo mortale al santo. Tutti i particolari di un’umanità brutale vengono esaltati, senza omissioni né sfumature, e i corpi nudi vengono introdotti in tutto il loro realismo. I colori sono cupi ed emergono dal chiaroscuro contrastato, le tonalità passano dall’ombra alla luce intensa. La maggior parte dei colori è calda, bruna, dorata o rossastra. L’unico ad essere illuminato è San Matteo, anche se non del tutto, mentre le altre figure hanno un’illuminazione funzionale alla composizione e alla resa teatrale e dinamica dello spazio.

I due dipinti, in particolar modo il primo, è rappresentativo della tematica giubilare: la luce, che investe i personaggi come una rivelazione, simboleggia la presenza di Dio nella storia e il suo intervento nel mondo, per combattere l’oscurità del peccato e del male. All’uomo-pellegrino spetta il compito di accogliere questa luce e di farsi inondare da essa, rendendosi disponibile e predisponendo il suo cuore ad incontrare il Padre. Tra i milioni di pellegrini al Giubileo del 1600 ci furono anche illustri letterati e religiosi. Lo scrittore napoletano Giovan Battista Marino (1569-1625), considerato a lungo il capofila della poesia barocca, sviluppata all’insegna di un’estrema sperimentalità sincretistica con l’uso di linguaggi diversi, si trovava a Roma proprio per quell’anno giubilare e, per l’occasione, da lì si recò a Loreto. San Camillo de Lellis (1550-1614), erede degli insegnamenti di San Filippo Neri, giunse a Roma nel 1600 con i suoi figli spirituali (i Camilliani). Dediti alla cura corporale degli infermi, parteciparono al pellegrinaggio delle Sette Chiese e assistettero gli ammalati che incontravano per le vie. Fu un segno di estrema carità durante quell’anno santo, un punto di riferimento per i cristiani che osservarono questo meraviglioso spettacolo di umanità, apprezzando la missione condotta dalla “Compagnia dei ministri degli infermi”, di cui Lellis fu fondatore. Questi e molti altri personaggi misero a disposizione i loro talenti, esaltando la missione della Chiesa a favore della salvezza delle anime.