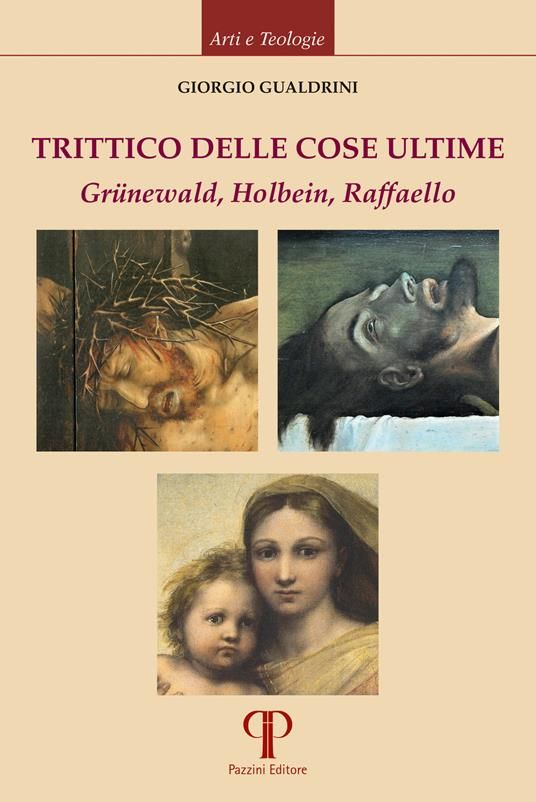Cultura
Conoscenza di Dio o relazione con Dio? Sul secondo canto del Paradiso dantesco
La teologia non è una sorta di addestramento intellettualistico necessario per affrontare il viaggio ultraterreno che attende ogni pellegrino

Nel secondo canto del Paradiso (vv. 1-18) Dante si dilunga in un monito rivolto ai suoi lettori con dei versi memorabili che riporto qui integralmente:
O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d’ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca,
tornate a riveder li vostri liti: non vi mettete in pelago, ché forse, perdendo me, rimarreste smarriti.
L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; Minerva spira, e conducemi Appollo, e nove Muse mi dimostran l’Orse.
Voialtri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan de li angeli, del quale vivesi qui ma non sen vien satollo,
metter potete ben per l’alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi a l’acqua che ritorna equale.
I versi sono troppo noti per dover essere qui minuziosamente esplicitati. Sostanzialmente, e in estrema sintesi, Dante avvisa il lettore digiuno di studi teologici sulle difficoltà che potrebbe incontrare durante il percorso che si accinge a compiere (non vi mettete in pelago, ché forse, / perdendo me, rimarreste smarriti). Queste terzine di ammonimento pongono però un problema assai difficile che in qualche modo, almeno in prima battuta, sembrerebbe intaccare in profondità il messaggio salvifico cristiano. Ponendo al lettore lo studio della teologia come criterio per proseguire o interrompere il viaggio ultraterreno sembrerebbe che Dante faccia collassare tutto l’impianto della vita cristiana – e le condizioni stesse della salvezza – verso una certa forma di razionalismo esacerbato. Per seguire il viaggio dantesco verso la visione divina, verrebbe da chiedersi leggendo questi versi, non è quindi sufficiente una fede sincera e la purezza del cuore? Il monito dantesco, invece, lascia intendere che lo studio della teologia avrebbe una sorta di potere trasformativo, quasi fosse interpretabile come una specie di addestramento intellettualistico necessario per affrontare al meglio il viaggio ultraterreno che attende ogni pellegrino. La vita cristiana, in questa inusuale prospettiva, finirebbe per assomigliare ad una certa forma di gnosticismo. Che forse sarebbe in qualche modo possibile riuscire a penetrare le verità cristiane più importanti (l’Incarnazione, la Trinità, il concepimento ad opera dello Spirito Santo) grazie alla speculazione teologica? Sarebbe quindi possibile ‘farsi trovare pronti ed addestrati’ per affrontare, in «piccioletta barca», un viaggio così impegnativo e radicale che ha come meta la visione di Dio? La teologia non ha di certo questo potere e, a ben vedere, il principio stesso della teologia, che è la fede, è proprio sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. Niente, nella definizione della fede in spirito cristiano, rimanda ad una certa forma di conoscenza talmente chiara da poter fungere come preparazione alla visione di Dio. Al contrario, in quanto argomento delle cose non apparenti, fa essere le cose di cui è sostanza sotto il segno della piena fiducia e non sotto il segno dell’apprensione intellettuale. In effetti l’apparente declinazione intellettualistica dei versi in questione contraddice in modo assai evidente la sfumatura che la teologia, che è l’orientamento generale di tutta la Commedia dantesca (essa è infatti un’opera in toto teologicamente orientata), assume complessivamente nelle tre Cantiche. Contrariamente a quanto questi versi iniziali sembrano suggerire, l’approccio teologico del Sommo Poeta è quello di «una teologia pratica, o di un “vissuto”» molto simile ad esempio a quanto si può desumere dall’itinerario degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola «che non mirano ad una didattica, ma registrano un vissuto» (I. Biffi, “Di luce in luce”. Teologia e bellezza nel Paradiso di Dante, p. 29). Deve esserci quindi un senso per il quale questi versi danteschi possano essere interpretati diversamente e non come una strana ed inaspettata ricaduta nel modello gnostico della conoscenza – nel senso di una conoscenza salvifica e trasformativa. Il monito dantesco, allora, che senso ha? Ebbene, ancora una volta è importante far riferimento alla concezione tomista e in particolare alle tre dimensioni in cui si articola la fede secondo l’Aquinate. L’aspetto più importante dell’atto di fede, tanto importante da costituirne il fondamento, non è dato dalla dimensione intellettualistica dell’apprensione delle verità di fede (credere Deum) né dalla dimensione volitiva, data dalla prontezza della volontà a credere a Dio e alla sua Rivelazione (credere Deo) bensì dalla relazione che il credente instaura con Lui (credere in Deum). Ebbene, in questo senso la fede non è solamente una forma di conoscenza (sebbene di natura diversa, essendo ricevuta per Rivelazione) né, tantomeno, è riconducibile soltanto alla volontà a credere alla Parola di Dio. Essa, invece, è primariamente la relazione stessa che il fedele instaura con Dio. È tale relazione d’amore, coltivata in vita da ogni sincero credente, a preparare il terreno del cuore alla finale visio beatifica. Queste considerazioni aiutano a delineare anche il profilo dell’ideale lettore dantesco. Egli non sarà mai un semplice erudito né un filosofo che da solo, fidando sulle sue forze limitate – umane per l’appunto – oserà percorrere il periglioso viaggio ultraterreno sul modello di Ulisse. Al contrario, il lettore ideale sarà colui che ha speso la sua vita mangiando il «pan de li angeli», ma lo avrà fatto non riducendo la teologia a disciplina – umana – fra le altre, bensì vivendola appunto come una relazione capace di dare un senso e una coerenza al mare magnum delle conoscenze cristiane, non dimenticando mai che il fides quaerens intellectum ha una valenza esistenziale prima ancora che conoscitiva.