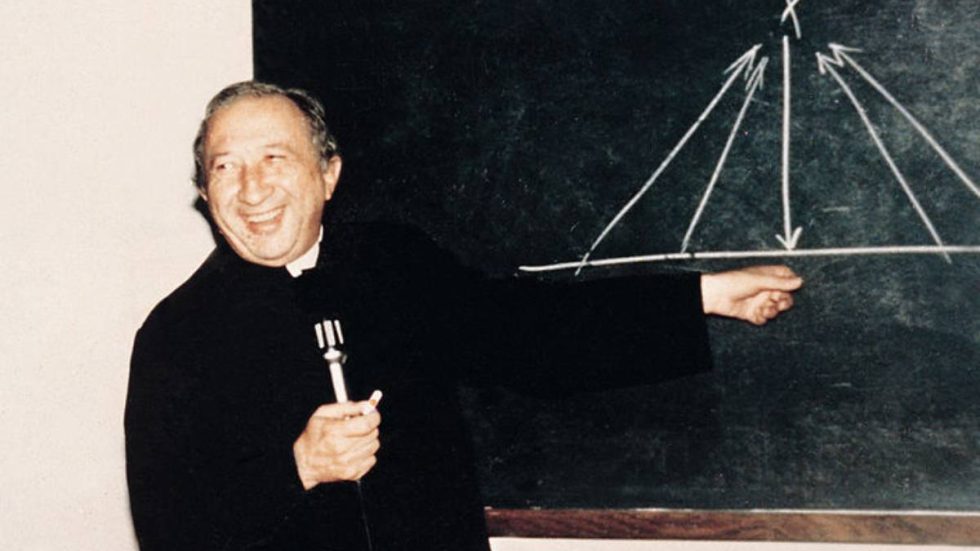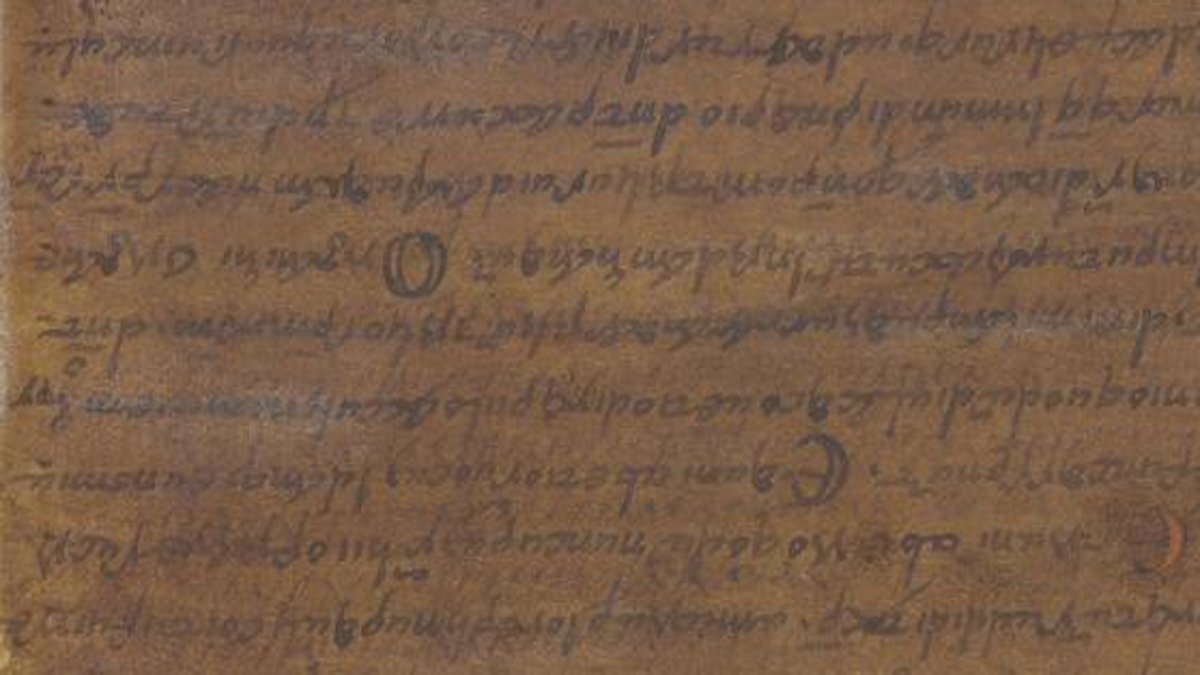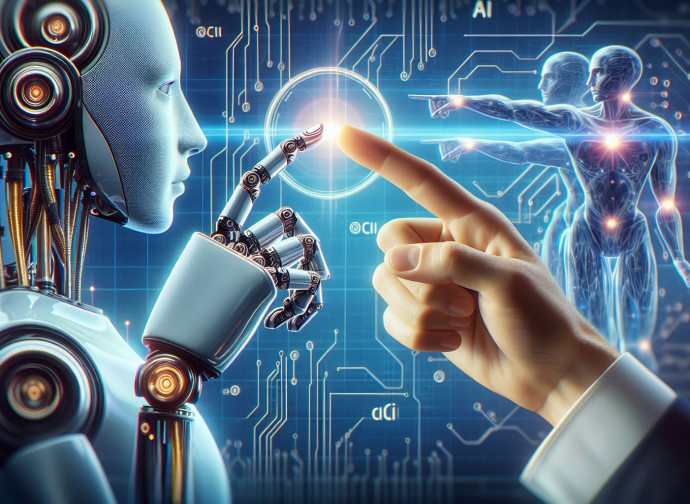Cultura
Il genio di Shakespeare continua a parlare ancora di noi
La recente trasposizione per il cinema (2015) di Macbeth, la tragedia che Shakespeare scrisse tra il 1605 e il 1606, diretta dall’australiano Justin Kurzel, interpretata da Michael Fassbender e Marion Cotillard ha in qualche modo fatto da battistrada alle inevitabili celebrazioni dei quattrocento anni dalla morte del grande inglese.

“La vita non è altro che un’ombra vagante: un povero attore che si pavoneggia e si agita per la sua ora sul palcoscenico, e poi tace; è un racconto recitato da un idiota gonfio di suono e di furia che non significa nulla”. Queste stupende parole, e terribili nella loro eterna capacità di fare luce sull’animo umano, provengono dai sensi di colpa di un uomo, Macbeth, che ha ucciso amici, antichi compagni di battaglie, donne e bambini per seguire un progetto, all’inizio confuso, e poi sempre più vivido nella sua atroce semplicità: la conquista del potere. La recente trasposizione per il cinema (2015) della tragedia che Shakespeare scrisse tra il 1605 e il 1606, diretta dall’australiano Justin Kurzel, interpretata da Michael Fassbender e Marion Cotillard ha in qualche modo fatto da battistrada alle inevitabili celebrazioni dei quattrocento anni dalla morte del grande inglese. Un battistrada rispettoso sicuramente del testo originale, avvolto in un’atmosfera cupa fin nella scelta dei colori e delle luci. Forse troppo. Perché ridurre solo ad azione-rimorso-punizione un testo della più feconda maturità del suo autore, che al tempo aveva più di quarant’anni, non gli rende giustizia. Già la statunitense Julie Taymor aveva tentato sei anni fa la strada del ritorno cinematografico a Shakespeare con “The tempest”, ma qui c’erano state delle novità, come l’effetto straniante scatenato dall’aver affidato ad una donna, l’attrice inglese Helen Mirrel, il ruolo di Prospero. E però pure qui, il testo originale era stato rispettato, anche nelle sue asperità, dovute a quattro secoli di cambiamenti linguistici. Dunque Shakespeare, a quattrocento anni dalla sua scomparsa, continua a incutere timore reverenziale, ma nello stesso tempo a suggerire nuove interpretazioni, e anche questo è il segno della sua capacità di essere continuamente moderno. Fino a diventare uno Shakespeare anti-Shakespeare, vale a dire un altro rispetto a quello che si credeva ieri. La studiosa Rita Sala, ad esempio, sostiene da tempo l’ipotesi che il grande scrittore non fosse per niente allineato con il regime elisabettiano, assai crudele con i dissidenti, specialmente i cattolici, ed anzi fosse nascostamente molto vicino ad essi. Altri hanno fatto notare come uno dei miti shakespeariani, l’amore, potrebbe non essere esattamente quel mito che sembra. Spezzando molti cuori cibatisi di Romeo e Giulietta, alcuni hanno insinuato che la tragedia dei due giovani amanti potrebbe voler dire addirittura l’opposto di quello che noi abbiamo sempre pensato. Per esempio che i due hanno pagato con la morte la loro avventata passione, l’infrazione di tabù familiari e sessuali. Che il voler dimenticare sé, il consegnarsi completamente nelle mani di un altro, fosse in realtà già di per sé un desiderio di morte, di rifiuto di ogni possibilità costruttiva e familiare. Come si vede, il genio lascia pensare tutto e l’opposto di tutto di sé e della sua opera.
Ancora oggi è impossibile non sentire un sottile brivido quando si legge per la prima, o rilegge per la centesima volta (sono queste le trappole dei geni) quel “To die, to sleep. To sleep, perchance to dream”, cioè “morire, dormire. Dormire, forse sognare” che ha aperto baratri di interpretazioni su che cosa sia davvero la vita per Shakespeare. E non solo per lui, perché lui è arrivato con il suo fascino fino ai grandi dubbi del Novecento. A Pirandello, per esempio. Come in quel passo che abbiamo posto in apertura in cui l’intrepido cavaliere, ora diventato un tiranno senza pietà (e trascinato da un “amore” divenuto ancora una volta ossessione, schiavitù, volontà di morte) si chiede se una vita interamente affidata al sogno di gloria, al potere, alla sua inesorabile fine, non sia altro che il delirio di un folle convinto di vivere ed invece consegnato auna morte inavvertita ma ancor più reale. Il Bardo di Strafford-on-Avon da più di quattrocento anni ci sta dicendo che non l’effimera fama, non la fugace apparizione sul palco, non il potere a tutti i costi ci daranno il senso profondo della vita, né ci indicheranno la strada per la pace e la felicità. Di noi si parla in queste storie, dunque, a quattro lunghi secoli di distanza. Ed anche questo è il segno del genio.