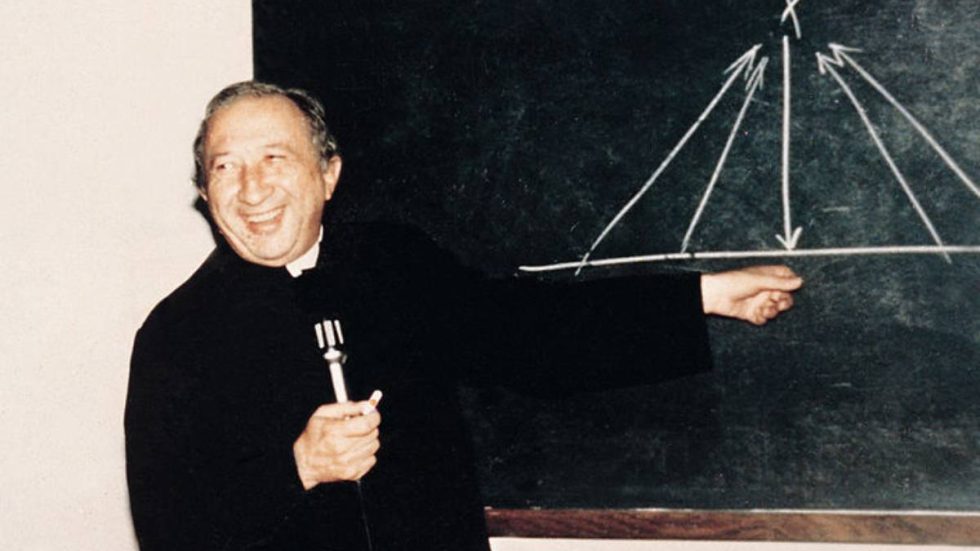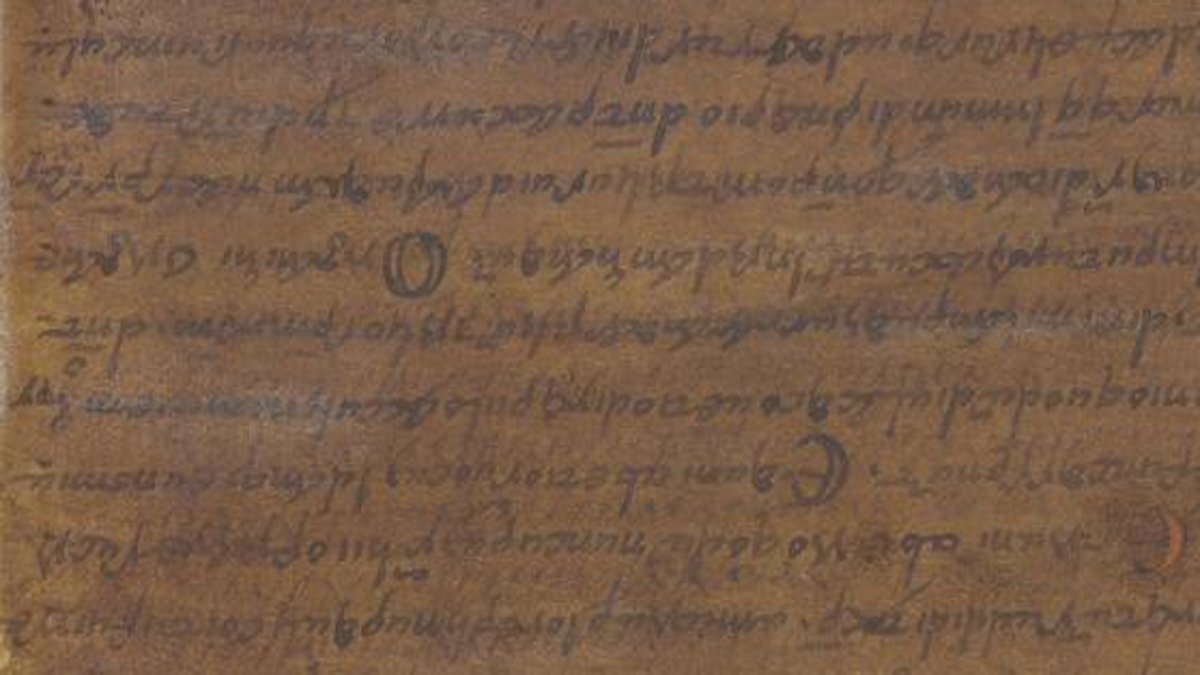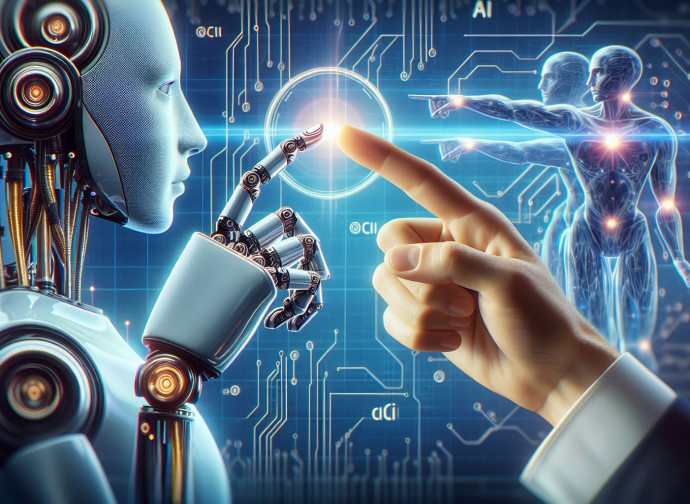Chiesa
Israele e Hamas. P. Patton (Custode Terra Santa): “Si vive incatenati dalla paura. Seminare fiducia per le prossime generazioni”
È trascorso un anno dall’attacco terroristico di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Da lì l’occupazione israeliana di Gaza e l’avvio di una campagna militare che, ad oggi, ha provocato, tra i palestinesi, oltre 41.500 morti, più di 96mila feriti e la distruzione di interi quartieri, comprese strade, scuole, ospedali e infrastrutture varie. Senza esito, finora, i negoziati. Abbiamo intervistato il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.

Un anno fa, il 7 ottobre 2023, l’attacco di Hamas contro Israele: migliaia di appartenenti a varie fazioni terroristiche palestinesi, provenienti dalla Striscia di Gaza, si sono infiltrati, via terra, via mare e dal cielo, in territorio israeliano uccidendo 1200 ebrei, tra civili e soldati, facendo scempio di uomini, donne, bambini, anziani che abitavano nei kibbutz e nelle città vicine al confine, come Sderot.
Kibbutz Be’eri assaltato da Hamas (Foto Sir)
In quello stesso giorno furono prese in ostaggio 250 persone; 101 di queste (al 26 settembre 2024, ndr.), di ben 21 nazionalità, sono ancora nelle mani di Hamas. Un brusco risveglio per lo Stato di Israele che in poche ore ha visto frantumarsi quel mito della sicurezza che lo aveva sempre accompagnato sin dall’inizio della sua storia. La risposta israeliana non si è fatta attendere con l’avvio di una campagna militare dentro Gaza che ad oggi ha provocato, tra i palestinesi, oltre 41.500 morti, più di 96mila feriti e la distruzione di interi quartieri, comprese strade, scuole, ospedali e infrastrutture varie. Una vera e propria emergenza umanitaria e sanitaria che coinvolge tutta la popolazione gazawa praticamente sfollata all’interno della stessa Striscia. Senza esito, finora, i negoziati, mediati da Usa, Qatar ed Egitto, per pervenire ad un cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi. Un anno dopo il 7 ottobre il Sir ha intervistato il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.
Che cosa è cambiato in Israele da quel 7 ottobre?È cambiato completamente il modo di vivere e di convivere. Prima del 7 ottobre c’era, seppur fragile, un equilibrio di convivenza e, in alcuni settori della società civile israeliana, anche di disponibilità e di apertura verso il mondo palestinese e viceversa. Quanto accaduto il 7 ottobre ha riportato le lancette della storia a prima del 1948, anno della nascita di Israele, ma con una diffusione nella cultura e nella comunicazione attuali, di odio, di rabbia, di paura, di polarizzazione e anche di rifiuto di ragionare. È evidente il rifiuto di vedere le conseguenze di quello che si sta facendo in prospettiva futura.
Ma rimettere insieme ‘i pezzi’ di una società come quella israeliana, traumatizzata dai fatti del 7 ottobre, è possibile?
Va detto che nella società israeliana vivono differenti anime, religiose e no. Ci sono partiti religiosi che sostengono politicamente il governo. Altri un po’ meno. Ci sono religiosi coi quali è possibile dialogare fruttuosamente e altri no. Ci sono, poi, i coloni fondamentalisti sia dal punto di vista religioso che del nazionalismo politico, questi hanno fatto un cortocircuito che ha prodotto una specie di messianismo nazionalista e fondamentalista. Va detto anche che gli ultraortodossi, noti anche come haredim, sono cosa diversa dai coloni: entrambi hanno posizioni differenti all’interno del Governo. E come dicevo poc’anzi, nella società israeliana esistono anche ambienti più laici e aperti al dialogo con i palestinesi e con gli israeliani di etnia araba. Ora per provare a rimettere insieme i frammenti di questa società servirebbe, a mio parere, un cambio culturale profondo che abbia come presupposto un’apertura di credito verso la controparte e cominciare a pensare che fidarsi, dialogare, convivere e accettarsi reciprocamente sia possibile.
Come dare forza a questo cambiamento culturale?Lo ha detto Rachel Goldberg-Polin, madre di Hersh, uno degli ostaggi uccisi da Hamas mentre era tenuto a Gaza: il cambiamento passa attraverso il riconoscimento del valore della sofferenza dell’altro. Israeliani e palestinesi devono comprendere la sofferenza gli uni degli altri reciprocamente. Questo significa riconoscere il diritto all’esistenza dell’altro, la sua dignità. È un ostacolo culturale, psicologico, in parte anche religioso, che, se non si supera, renderà difficile, se non impossibile la convivenza. Chi dovrebbe favorire la rimozione di questo ostacolo è la leadership politica e religiosa dei due popoli. Purtroppo, in questo momento sembra prevalere, nei due contendenti, solo il desiderio di eliminazione dell’altro.
I fatti del 7 ottobre 2023 hanno sfatato il mito della sicurezza di Israele…La paura e l’incertezza c’erano anche prima. Basterebbe vedere quei grandi tabelloni rossi, situati nei pressi dei check point militari, che avvertono gli israeliani di non entrare nei Territori palestinesi per motivi di sicurezza. Questo fa capire che i rapporti con i palestinesi sono stati sempre improntati alla mancanza di fiducia e segnati dalla paura. Parlerei, dunque, di una falsa sicurezza alimentata dal muro che separa Israele dalla Cisgiordania e da Gaza, e dalla convinzione che, al confine con il Libano, Hezbollah possa essere controllato militarmente. Io credo che l’idea di paura appartenga all’inconscio collettivo del popolo ebraico ed ha una giustificazione storica. Anche in questo caso c’è bisogno di quel cambiamento di cui parlavo poco fa e ben delineato dalle parole di Rachel Goldberg-Polin e di altri familiari di ostaggi nelle mani di Hamas. Purtroppo, ho l’impressione che buona parte degli israeliani, in questo momento, appoggi l’azione militare del Governo, forse anche per un desiderio di vendetta e di deterrenza basata sul terrorizzare l’altro, pensando che questo basti a bloccarlo, ma questo in realtà alimenta la rabbia che prima o poi esplode in violenza. Basti vedere cosa sta accadendo nella Striscia di Gaza. Ma una pace indotta dalla paura non è pace.
È forse la paura il sentimento che oggi prevale nei due popoli?Si percepisce la paura da una parte e dall’altra, tra gli ebrei, i musulmani, i cristiani. Questi ultimi si sentono frustrati e ormai schiacciati e inermi davanti ai tanti problemi provocati dalla guerra, come la disoccupazione, e a una crescente criminalità sociale di tipo mafioso interna alla comunità araba e scarsamente combattuta dalla polizia e dalla sicurezza israeliana. Si vive nella paura a Gaza, in Cisgiordania, nel Nord di Israele, in Libano. Nel Paese dei Cedri i frati della Custodia hanno paura di diventare degli obiettivi di Israele perché stanno accogliendo nei nostri conventi sfollati libanesi che hanno perso case e averi. Si vive incatenati dalla paura. C’è poi un’altra cosa…
Quale?Da quando è cresciuto di intensità il conflitto al confine con il Libano, non si parla più di Gaza. Gaza è sparita dalla cronaca con tutto il suo carico di morte, di distruzione, di odio. E lo stesso sta accadendo per la Cisgiordania dove continuano i raid di Israele. È un fenomeno tipico della comunicazione del nostro tempo: oggi si parla solo di Libano, domani si vedrà. La stessa informazione è ormai sottomessa alla logica della spettacolarizzazione e l’opinione pubblica guarda alle notizie non per informarsi ma come gli spettatori guardavano i gladiatori ammazzarsi nel Colosseo. Così stiamo perdendo umanità.
Cosa pensa dell’impegno messo in campo dalla comunità internazionale in questo anno per trovare una soluzione al conflitto in corso a Gaza?La comunità internazionale si sta dimostrando impotente nel fare pressione sui belligeranti affinché cessi l’azione militare e si arrivi ad un accordo negoziato. Si stanno dimostrando impotenti i paesi occidentali e quelli del mondo arabo, entrambi di fatto stanno continuando ad alimentare e finanziare il conflitto. Se non si taglia il flusso di denaro e se non si blocca il rifornimento di armi – come sottolinea, spesso irriso, Papa Francesco – è molto difficile che si possa arrivare a una conclusione del conflitto. Dal mio punto di vista la comunità internazionale si è dimostrata impotente e priva di una volontà reale ed efficace.
Come giudica, invece, quello delle religioni? La Terra Santa, ricordiamolo, è il centro delle tre grandi fedi abramitiche, ebraismo, cristianesimo e islam.Direi che è stata un’azione dall’efficacia molto limitata soprattutto in merito alla capacità di trasformare la cultura della società. I leader religiosi devono smetterla di giustificare, in termini religiosi, l’uso della violenza. Occorre reinterpretare seriamente i testi violenti presenti nelle scritture sacre di ebrei, cristiani e musulmani alla luce della misericordia che è il nucleo centrale e comune del messaggio religioso dell’Antico e del Nuovo Testamento, così come del Corano. Se non riusciamo a fare questo, continueremo a trovare nei testi sacri giustificazioni per la violenza, come sta accadendo oggi.
Come evitare questa deriva pericolosa?La strada da percorrere potrebbe essere quella di un nuovo documento di Abu Dhabi, multilaterale, non più firmato da un Papa cattolico e da un imam sunnita, ma sottoscritto anche dai principali capi cristiani, ebrei e musulmani. Ma poi un testo del genere avrebbe bisogno di diventare oggetto di formazione e di catechesi per raggiungere tutti gli strati sociali dei credenti. Attualmente l’unico leader capace di mettere in moto questo processo è Papa Francesco. Come cristiani dobbiamo e dovremo lavorare molto per promuovere la fiducia, la convivenza, il dialogo e l’accoglienza reciproca. Piccoli segni profetici ma dal grande valore. In Medio Oriente c’è un proverbio che dice che chi pianta fragole pensa alla prossima stagione, chi pianta datteri pensa alla prossima generazione: noi dobbiamo pensare alla prossima generazione e accettare di fare un lungo percorso di semina e di coltivazione di una cultura della fiducia reciproca, della riconciliazione e della convivenza se vogliamo che la prossima generazione possa raccogliere i frutti della pace.