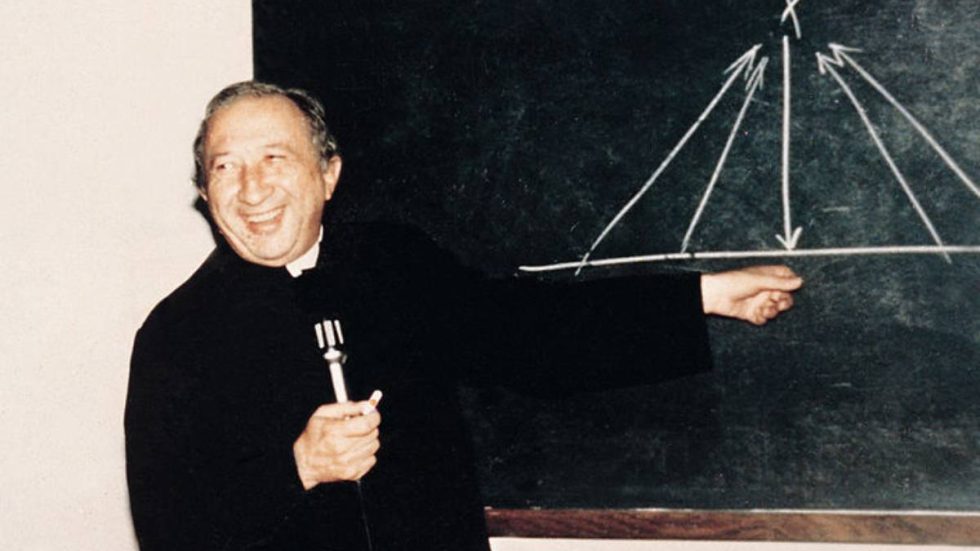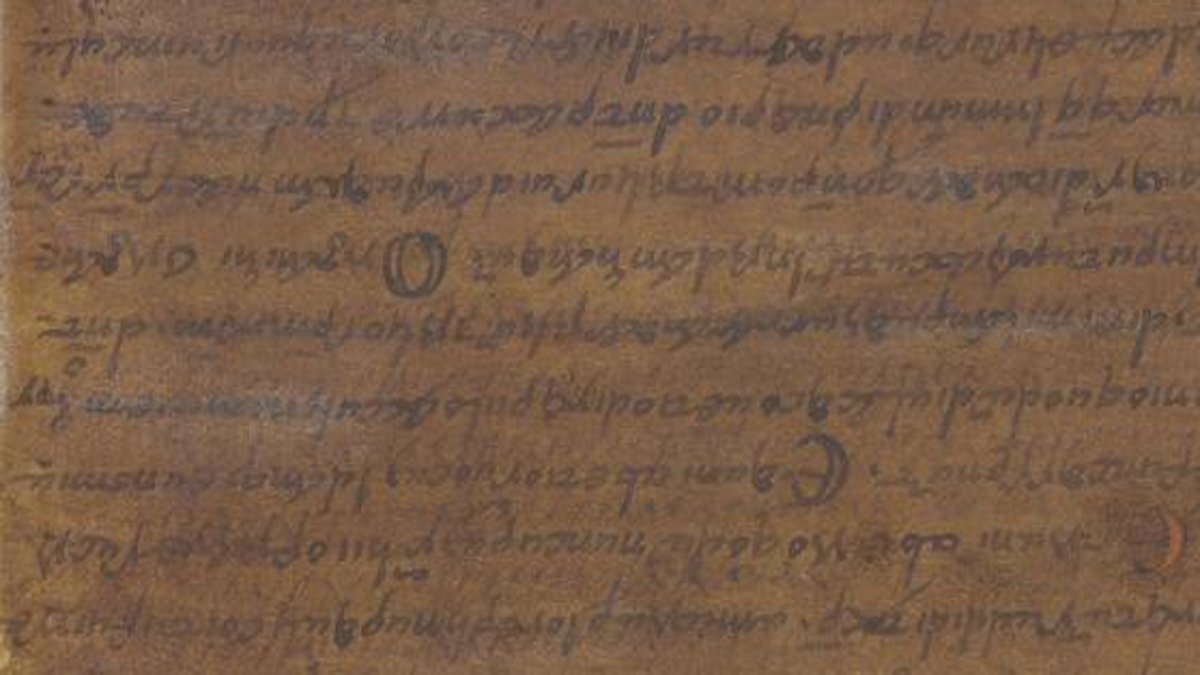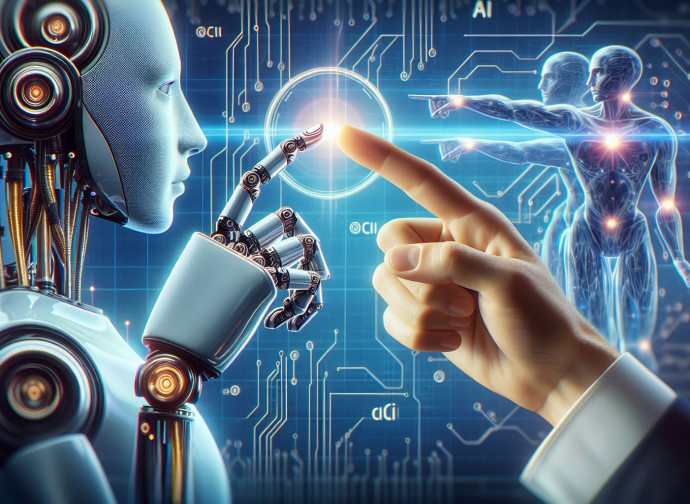Cultura
La guerra di Nina. L’amore, il dolore e la guerra in Siria
Imma Vitelli reporter di guerra e scrittrice, finalista al Premio Stresa 2021, si racconta ai lettori di Parola di Vita: l’orrore e rinascita dalle ceneri


Reporter di guerra in Medioriente, donna di fine sensibilità e scrittrice che di fatto ha vissuto sulla propria pelle, in primis, le sue personali guerre attraverso la cronaca delle guerre di altri popoli. Si tratta di Imma Vitelli, originaria di Matera che, con coraggio, ha perseguito il suo sogno di testimoniare con la “penna-qwerty” la complessità dei conflitti bellici: Imma Vitelli ha regalato, a noi lettori onnivori, un romanzo tutto da gustare, parola per parola, La guerra di Nina (Longanesi). Una narrazione che, a buon diritto, è arrivata tra i finalisti del Premio Stresa 2021.
Quanto di Imma c’è in Nina?
Credo che in Imma ci sia tantissimo di Nina, ma in fondo ognuno dei personaggi che ho creato nel romanzo occupa uno spazio mentale che è il mio. Per quanto riguarda Nina, ci sono delle parti di me e della Imma che sono stata: da un punto di vista autobiografico, Nina è la giovane reporter di guerra, irruenta e idealista, che a un certo punto, dopo l’11 settembre 2001, lascia il lavoro sicuro in una prestigiosa redazione a Roma, per catapultarsi nei tumulti del Medioriente. Nina, inoltre, è lucana come me; alla maniera di Philippe Roth, che ha ambientato tutti i suoi romanzi in New Jersey, noi scriviamo di ciò che sappiamo, di ciò che conosciamo. Però, a differenza di Nina, non sono stata mai rapita in Siria, terra in cui è ambientato il romanzo, né ho mai avuto una torrida storia d’amore con un fotografo siriano. Ho mischiato frammenti di autobiografia a fatti storici con una tecnica romanzesca, che cerca di amalgamare il tutto come le voci di una polifonia.
È stato difficile recuperare frammenti di Imma per dare vita alla storia di Nina?
In realtà, ciò che ti tocca di più nel profondo, coincide anche con i momenti di svolta nella nostra vita, nell’attimo in cui qualcosa accade o lo facciamo accadere. Ecco, quei momenti sono sempre con noi: può sembrare un paradosso, ma è molto facile ritrovarli perché ce li portiamo dentro. Una delle cose che ho scoperto è che ogni crescita è temporanea: e io, ora, sono in grado di guardare alla persona che sono stata e di ritrovare quei sentimenti proprio perché ho lavorato a lungo su di essi, per potermene astrarre e per osservare la giovane donna che sono stata in quegli anni di guerre, anche esistenziali. Quindi la reale difficoltà, per me, è stata piuttosto l’intrecciare i diversi piani in un’unica voce armonica, in un’unica lingua, che li tenesse assieme: il personale e il politico.
Si guarisce mai dal “mal di guerra”?
Sì, io lo posso testimoniare. Anzi, credo per questo di avere scritto il libro e che esso rappresenti per me, da questo punto di vista, una pietra miliare: ancora Philippe Roth affermava che si scrive sempre a partire dalle proprie ceneri: si può scrivere per davvero, solo dopo avere messo una certa distanza tra sé e una parte di sé. Penso che per andare in guerra, in fondo, “la guerra” un po’ la devi avere dentro. Nessuno dei miei colleghi, quando andavamo al fronte, era dissimile da me: tutti ci portavamo dentro dei conflitti e delle perdite. Personalmente, ho smesso di vivere la guerra per raccontarla, quando ho fatto la pace con me stessa. Per cui la buona notizia è che, frequentando molto il passato, guardandolo da punti di vista diversi, è certamente possibile guarire dalla guerra, e da tutte le “proprie guerre”.
La sua famiglia come ha reagito dinnanzi alla sua scelta?
Sono andata via di casa a 15 anni per giocare a pallavolo da professionista, per cui ho imparato presto a scegliere autonomamente, “scrollandomi” di dosso le influenze familiari e cercando di seguire sempre “la forza del desiderio” dentro di me, la mia vocazione. Per cui, quando ho scelto di lasciare la pallavolo per andare negli USA per gli studi, mi sono sempre limitata a informarli delle mie scelte. Ricordo l’ultimo giorno dello praticantato presso il gruppo Repubblica-Espresso il lavoro di redazione non mi stava dando niente. Volevo raccontare la guerra, inseguendo la mia autentica aspirazione. Ho sempre creduto di essere una “testimone”. Ricordo che il direttore di allora, Paolo Galimberti, quando gli comunicai la mia scelta mi disse: “Sei pazza!”. Da un lato, da spirito libero, ho sempre scelto altrettanto liberamente, accettando tutte le conseguenze; dall’altro, però, devo riconoscere che l’essere andata via di casa da adolescente, mi ha reso fragile per certi aspetti, come ad esempio cercare figure parentali in amici o in altre persone.
Guerra e Amore. In zone “calde” come la Siria l’amore, in mezzo a tanto orrore, dove lo ha trovato?
L’ho trovato: dove c’è odio, c’è anche amore. In guerra, tutto ti appare in maniera estrema e chiara. Non esiste la linea dei grigi: è tutto molto palese, dai contorni nitidi e ben definiti. Ho assistito a scene di puro odio e a testimonianze truci. Mi viene in mente, nel 2016, la storia di una madre siriana: era scappata dalla sua città, Raqqa, e aveva trovato rifugio in nuova località. Qui, l’orrore conseguenza della guerra: va a vedere il suo bambino, che giocava a palla in giardino con altri bambini. Poi aveva visto la “palla”: era la testa di un uomo, decapitato dallo Stato Islamico. Un’altra volta, invece, ho intervistato un mistico dell’Islam, che è rimasto sotto assedio ad Aleppo durante i bombardamenti russi. Si sapeva che Aleppo sarebbe caduta: morivano, ogni giorno, circa 300-400 persone. E lui, il mistico, che avrebbe potuto lasciare la città, trovando riparo a Istanbul; invece era rimasto per consolare i poveri, laddove la guerra falcia, soprattutto i poveri e i più deboli. E cantava a loro i canti e le loro preghiere, meravigliose, per confortarli: ecco, questo per me è amore. E in guerra, il bene e il male, gli estremi che animano il nostro spirito, sono più visibili, più potenti, più palpabili. E proprio alla luce di questi eventi vissuti, ho deciso di scrivere una storia di amore e di guerra: la storia di Nina.
Che cosa consiglia ai giovani che vogliono fare i giornalisti oggi?
Di studiare moltissimo e di conoscere quanto più possibile. Di uscire per strada e battere, palmo a palmo, tutta la Calabria; di sporcarsi le mani per raccontarla. Questo è un periodo nevralgico per entrare nella professione, ma anche carico di opportunità. Però è necessario appropriarsi di uno sguardo: noi stessi siamo “uno sguardo”, un punto di vista. Che cosa vogliamo raccontare dell’altro? E in che modo vogliamo raccontarlo? Ogni storia ha una sua prospettiva: dalla sala concertistica a Cosenza, alle realtà più dimenticate. Cercate di diventare bravi, in tal senso, curando il vostro giardino interiore, la vostra intelligenza. Come? Studiando tantissimo per capire il proprio talento, la ricerca del quale alla fine diventa anche una “ossessione”: la sensibilità di ognuno va affinata, dunque, con il duro lavoro. Per cui non fatevi deprimere dalle voci di quegli adulti che vi dicono “in Calabria non troverete mai lavoro”. Non bisogna combattere per trovarlo ma lo si crea, se lo si vuole e se si studia.