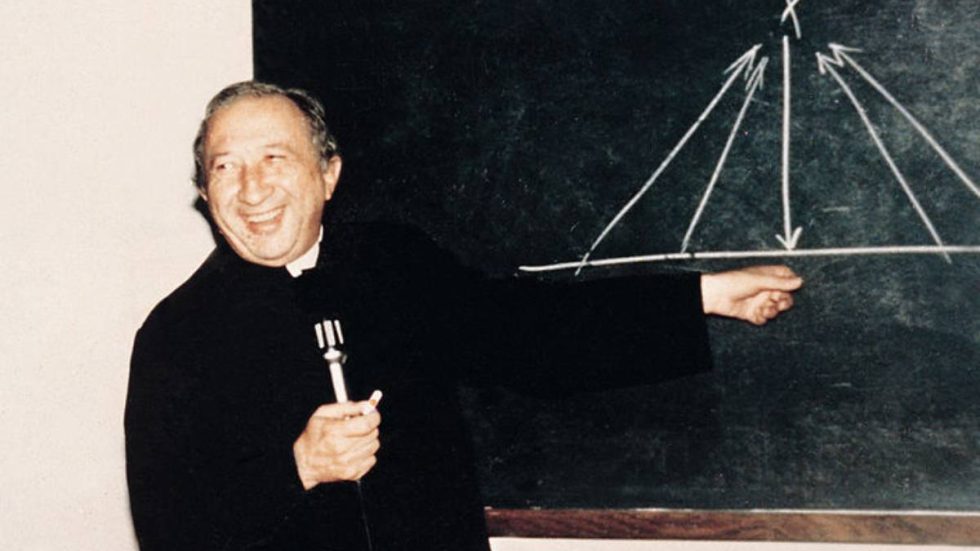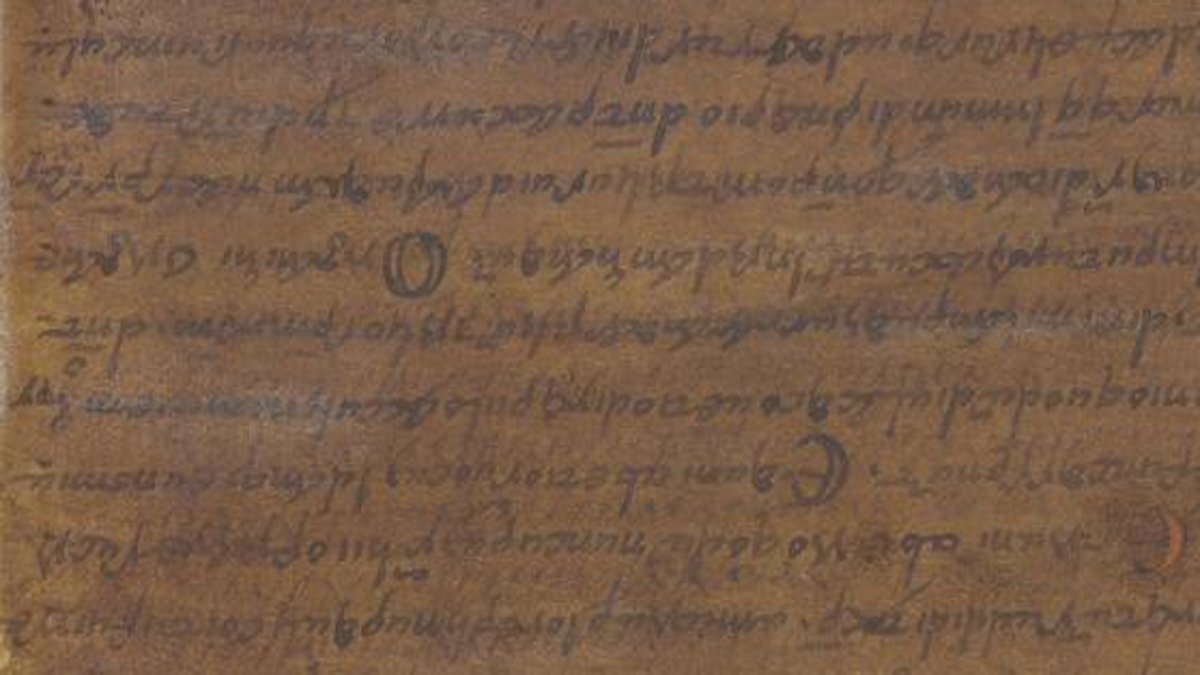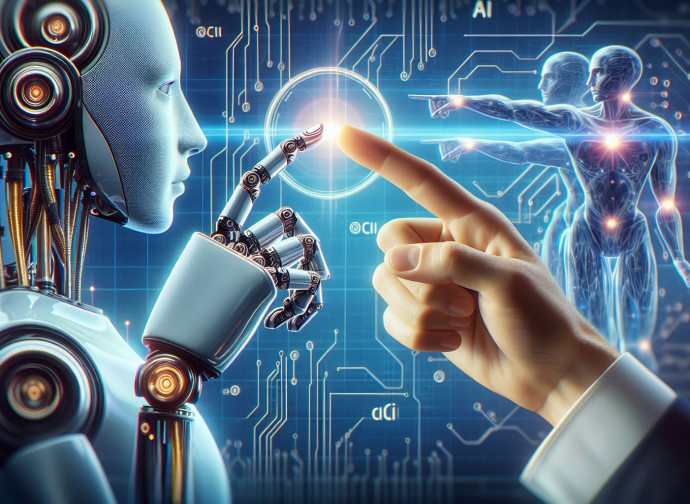Cultura
“Non lasciatemi solo”
Le liriche di Gian Citton contro il rischio della solitudine e della disperazione
La cosa più importante che “non” scrivo è sussurrata sotto-carta come sottovoce a sera un “buona sera” timido a qualcuno che ricambi il saluto- Il chiù dell’assiolo che chiama nella notte: -Non lasciatemi solo-.
Gian Citton è solo apparentemente passibile di collocazione geografica: certamente di area linguistica veneta, visto che è nato a Feltre, vicino Belluno, ma in grado di raggiungere corde profonde dell’animo umano, in qualsiasi parte del mondo si viva. Anzi, l’uso, in verità assai parco e intelligente, del dialetto, sdrammatizza e nello stesso tempo aiuta ad “entrare” nella dimensione popolare del racconto poetico. Nella raccolta “La provincia dei cani” (Book Editore, 96 pagine), che raccoglie poesie scritte tra il 1999 e il 2015, Citton raggiunge livelli decisamente alti di corrispondenza tra parola, suono, pensiero e coinvolgimento del lettore. D’incanto spariscono i lamenti amorosi, le elucubrazioni più o meno filosofiche sul destino dell’uomo, quelle banalizzazioni che hanno allontanato purtroppo il lettore contemporaneo dalla poesia, che invece dovrebbe rappresentare un elemento profondo di educazione alla bellezza e al senso delle cose. Queste, le cose, riaggallano alla coscienza di tutti, non rimangono chiuse dentro la mediocrità di versi impotenti e farraginosi, di giochi di parole o di compiacimenti estetizzanti. No: qui le parole emergono nella loro necessità, alludono a profondità non più insidiate dalla banalità del loro uso improprio. È il miracolo della poesia. L’autore c’entra, perché certo, è lui che scrive, sicuramente ha lavorato sulla propria scrittura, ma qui si sente che affiora una vena nativa che viene dalle radici, dal latte materno. Il dono della poesia, semplicemente. La prima lirica, “Il Sessantotto di Adelina” è fulminante: dedicata ad una donna scomparsa proprio nel Sessantotto – e si noti il gioco di parole basato sull’uso di quella data per indicare la partecipazione alle lotte studentesche – essa è artiolata tutta su una domanda: “L’Adelina ricorda?” cui rispondono le cose quotidiane, gli oggetti della vita di ogni giorno, le abitudini, la malattia, la scomparsa. La vita, insomma. Ma qui questa vita, apparentemente consegnata all’oblio e forse al sospetto dell’inutilità, diventa epica di una lotta inesorabile e umilmente grandiosa contro il non-senso. Emerge una profondissima pietas mai pronunciata, ma tutta nelle cose, immersa in quella vita e in quello sguardo apparentemente inesorabile, in realtà carico di commozione che non deve essere gridata, se mai solo suggerita, pena la sua teatralizzazione e quindi la sua sterilizzazione: “Che è l’umido della cucina – e sempre il fradicio/ dell’ottomana – e sempre i chicchi/ di valium che ne ha perso il conto/ a sgretolarli a uno a uno i giorni/ sulla sua faccia a cinquantotto anni”. Il sessantotto di Adelina è da ricordare semplicemente perché è stato “bruciato nella febbre”. Che c’è di più omerico, di più eroico, in questa vita silenziosa diventata epica grazie alla poesia che l’ha salvata dal vero mostro, quello della dimenticanza? Un vero atto d’amore nascosto in questo guardare gli altri e riuscire a salvarli nella memoria collettiva, così come ha fatto Manzoni per due poveracci per di più inseguiti dal prepotente di turno, come ha fatto Chesterton per il suo uomo “che fu giovedì” e che diventa la vera statua immortale in un parco di Londra.Come nei versi riportati qui in apertura, in cui il poeta svela il vero segreto della poesia e dell’accanirsi, ai tempi del web e del consumo ossessivo, a inseguire spazi bianchi sui fogli elettronici: la ricerca dell’altro, la resistenza sui bastioni d’occidente contro l’attacco dell’indifferenza e di un narcisismo mortale. Quel non “non lasciatemi solo” è la chiave di tutto, al di là delle finzioni e delle ruote pavonesche, espresso in sole tre semplici parole. Grazie alla poesia.