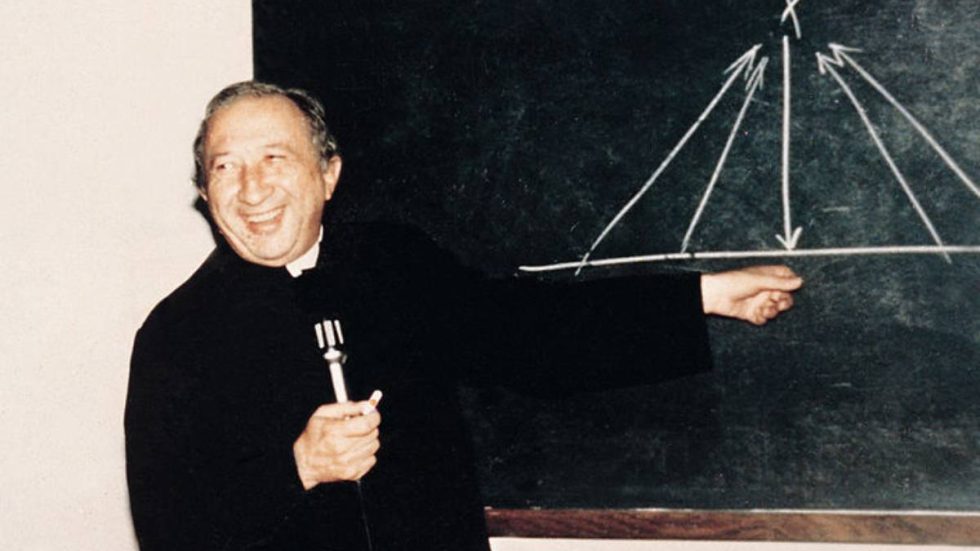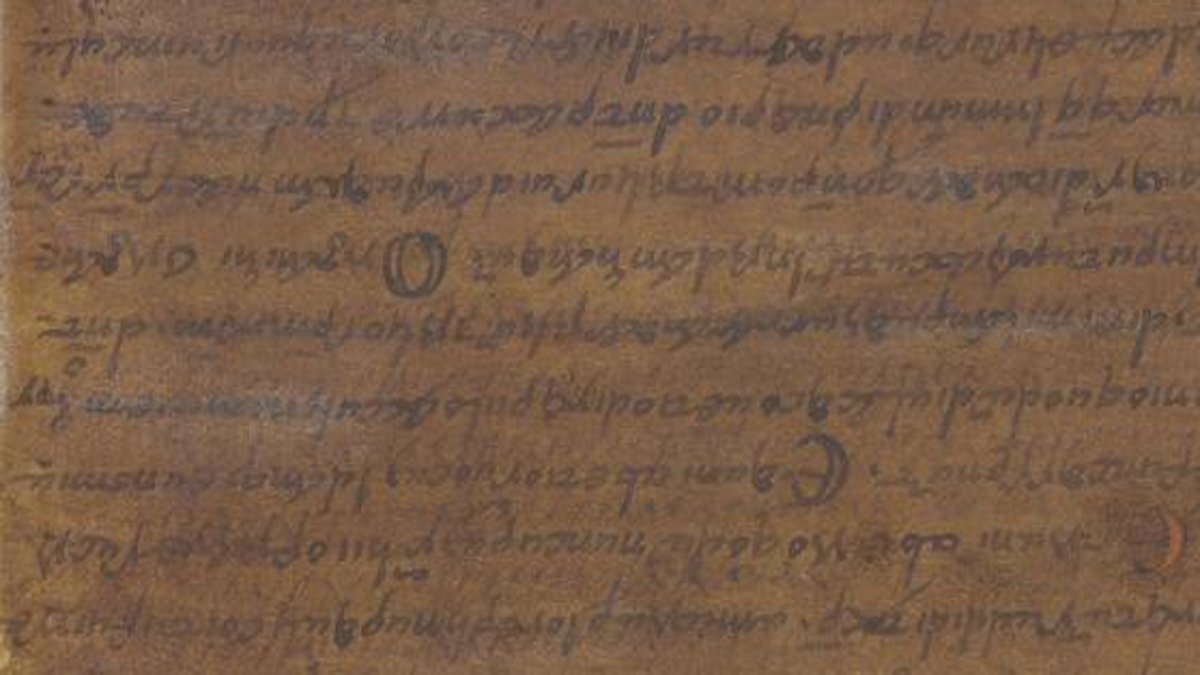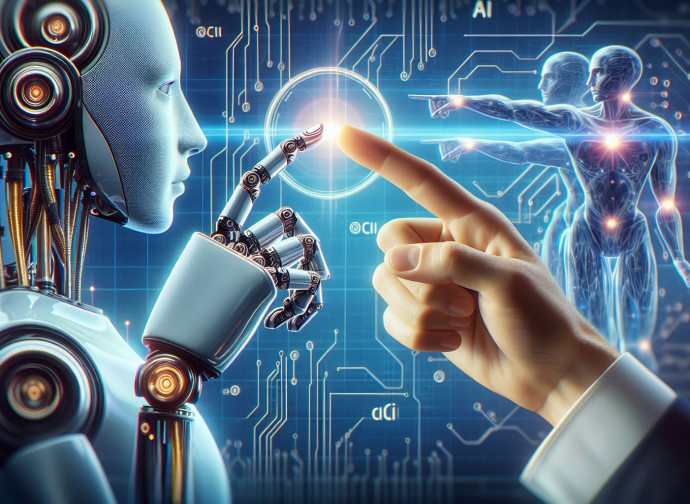Chiesa
Quale prete per la Chiesa italiana? Un uomo tra la gente
All'Assemblea generale della Cei di maggio si parlerà di rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente. Per monsignor Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, "la qualità di vita dei presbiteri sta attraversando un periodo di sofferenza" e dunque "dobbiamo ripensare insieme il nostro modo di essere preti". L'importanza del discernimento per l'accesso al sacerdozio, il rapporto con i laici e i religiosi.

Quale modello di prete sogna la Chiesa italiana? Monsignor Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale delle vocazioni, ha le idee chiare: “Un presbitero vicino alla gente che sia uomo della Parola, della grazia e della misericordia”. A pochi giorni dalla 53ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (17 aprile), mons. Dal Molin certifica lo stato di salute del clero italiano in vista della prossima Assemblea generale della Cei che sarà dedicata al rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente.
A quale figura di sacerdote tende la Chiesa italiana?
Sulla spinta della Pastores Dabo Vobis di Giovanni Paolo II, la Chiesa italiana ha puntato sulla formazione permanente e sul presbitero come uomo della carità pastorale. L’entusiasmo del post-Concilio, però, si è affievolito nel tempo, anche per l’emergere di una serie di compiti accessori che vanno dall’amministrazione della parrocchia alle mansioni burocratiche. Vogliamo rilanciare il modello di un prete che sia uomo di Dio e prossimo alle persone. “Esperti in umanità”, come diceva Paolo VI, ma anche nella Parola.
Cambierà il rapporto dei vescovi con il clero diocesano?
I vescovi sono i pastori della comunità e le guide dei loro preti. È importante che vivano una paternità episcopale, dando priorità all’incontro con il presbiterio, mentre è necessario che i preti sperimentino un maggiore senso di appartenenza. Risuonano le parole di Papa Francesco all’episcopato brasiliano: “Cari Fratelli, se non formeremo ministri capaci di riscaldare il cuore alla gente, di camminare nella notte con loro, di dialogare con le loro illusioni e delusioni, di ricomporre le loro disintegrazioni, che cosa potremo sperare per il cammino presente e futuro?”. La Chiesa non è un “transatlantico alla deriva”, aggiunse in quell’occasione, ma segue sempre una “bussola”. Ebbene, il prete deve essere attento alle attese e alle disillusioni delle persone, ma durante la notte non può smarrire la strada perché guidato dalla bussola della fede.
Anche la formazione permanente torna al centro dell’attenzione.
La qualità di vita dei presbiteri sta attraversando un periodo di sofferenza. Anche se i numeri non sono catastrofici, e in Italia continuano a esserci circa 33mila preti compresi quelli non nativi, si avverte la fatica e l’affanno legato a tante attività che distolgono l’attenzione. Il prete italiano ha sempre avuto la caratteristica di essere un uomo tra la gente, presente nei momenti significativi della vita delle persone. È un tratto unico nel panorama europeo. E poi si percepisce lo sforzo di mantenere un certo livello di formazione culturale e di vita spirituale. Se vengono meno queste dimensioni, la vita del prete va in difficoltà. Per tali ragioni è decisivo tornare a mettere al centro la formazione permanente.
La tendenza ad isolarsi è pericolosa per il sacerdote?
Dopo il Concilio, è iniziato un lungo percorso che ha portato dalla declinazione al plurale della vita del prete a una forma quasi individualistica, oggi diffusa tra le giovani generazioni. Nonostante la vita di seminario formi alla vita comunitaria, l’ordinazione sacerdotale talvolta viene vissuta come una liberazione che permette di tornare ai propri spazi e a una certa autoreferenzialità. E questo non è un bene.
Dunque, si chiede un cambiamento impegnativo?
Sì, perché andiamo a toccare lo stile di vita del prete. Non si tratta più di formazione permanente come corso di aggiornamento o settimana di ritiro. Certo, sono tutte cose necessarie, ma l’essenziale è altrove. Dobbiamo ripensare insieme il nostro modo di essere preti.
Cosa fa la Chiesa italiana per stimolare nuove vocazioni?
Un grande lavoro nascosto, perché la pastorale vocazionale non è fatta di grandi eventi. La sfida è lavorare sulla formazione e sulla motivazione degli animatori. È un servizio apparentemente in perdita, si semina oggi perché qualcun altro possa raccogliere domani. Per questo è fondamentale vivere il senso di gratuità e di rispetto delle persone, nonostante ci siano ancora situazioni di reclutamento legate al passato e all’ansia dei numeri. Ma Francesco non lascia spazio a dubbi nella Evangelii Gaudium: “Non si possono riempire i seminari sulla base di qualunque tipo di motivazione, tanto meno se queste sono legate ad insicurezza affettiva, a ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere economico”.
C’è il rischio di un discernimento poco attento nell’accesso al sacerdozio?
Il discernimento è una cosa seria, deve verificare l’idoneità delle persone e non interessarsi dei numeri. Anche per questa ragione riteniamo importante la formazione all’accompagnamento spirituale, al fine di aiutare le persone a compiere scelte. È un passaggio decisivo in un’epoca della non-scelta, in una cultura che invita a non impegnarsi. Vogliamo essere presenti sul territorio, a contatto con i centri vocazionali diocesani, i presbiteri, i laici e le famiglie, per mostrare che l’annuncio vocazionale non va per delega. È rivolto a ciascuno di noi. Tutti siamo responsabili delle vocazioni all’interno della Chiesa.
Come invertire o arrestare, allora, il calo delle vocazioni?
Oggi la vera pastorale vocazionale passa per la testimonianza di vita. Nel passato potevamo contare su una grande forza che derivava dal senso di appartenenza a una comunità. Adesso è arrivato il tempo di tornare ad annunciare la fede: dove ci sono figure significative di preti, religiose, consacrati o coppie si genera un entusiasmo che attrae. Per dirla con il Papa, la missione cristiana non è “fare proselitismo”. E poi non dobbiamo dimenticare i laici e i religiosi…
In che senso?
C’è un risveglio di consapevolezza vocazionale tra i laici e su questo aspetto bisognerebbe lavorare. Noto la sensibilità di coppie e di famiglie coscienti che il prete non può lavorare da solo. Sogno una Chiesa in cui, seppure diminuiscono i preti, ci sia un senso di corresponsabilità che valorizzi anche la vita consacrata. Sarebbe una risorsa preziosa, in un tempo di debolezza, per il servizio pastorale. Non siamo ancora arrivati ad avere comunità cristiane tanto accorte e generative, ma la strada da percorrere è quella giusta.
Stanno cadendo anche gli ultimi steccati che dividevano il clero diocesano e i consacrati?
Fino a cinque o dieci anni fa, la pastorale vocazionale era gestita in proprio dagli Istituti religiosi. Ora si avverte un forte bisogno di sinergia. Emerge il desiderio di condividere e di partecipare, senza sprecare energie. Bisogna uscire dai recinti, nell’ottica di una maggiore collaborazione. Alcuni pregiudizi sono già stati superati. I religiosi possono condividere ancora di più l’identità di profezia e di carisma all’interno delle comunità cristiane e tra i preti. Dobbiamo far conoscere la vita consacrata ai seminaristi, che non la frequentano molto, e chiedere ai religiosi di affacciarsi nelle nostre realtà.